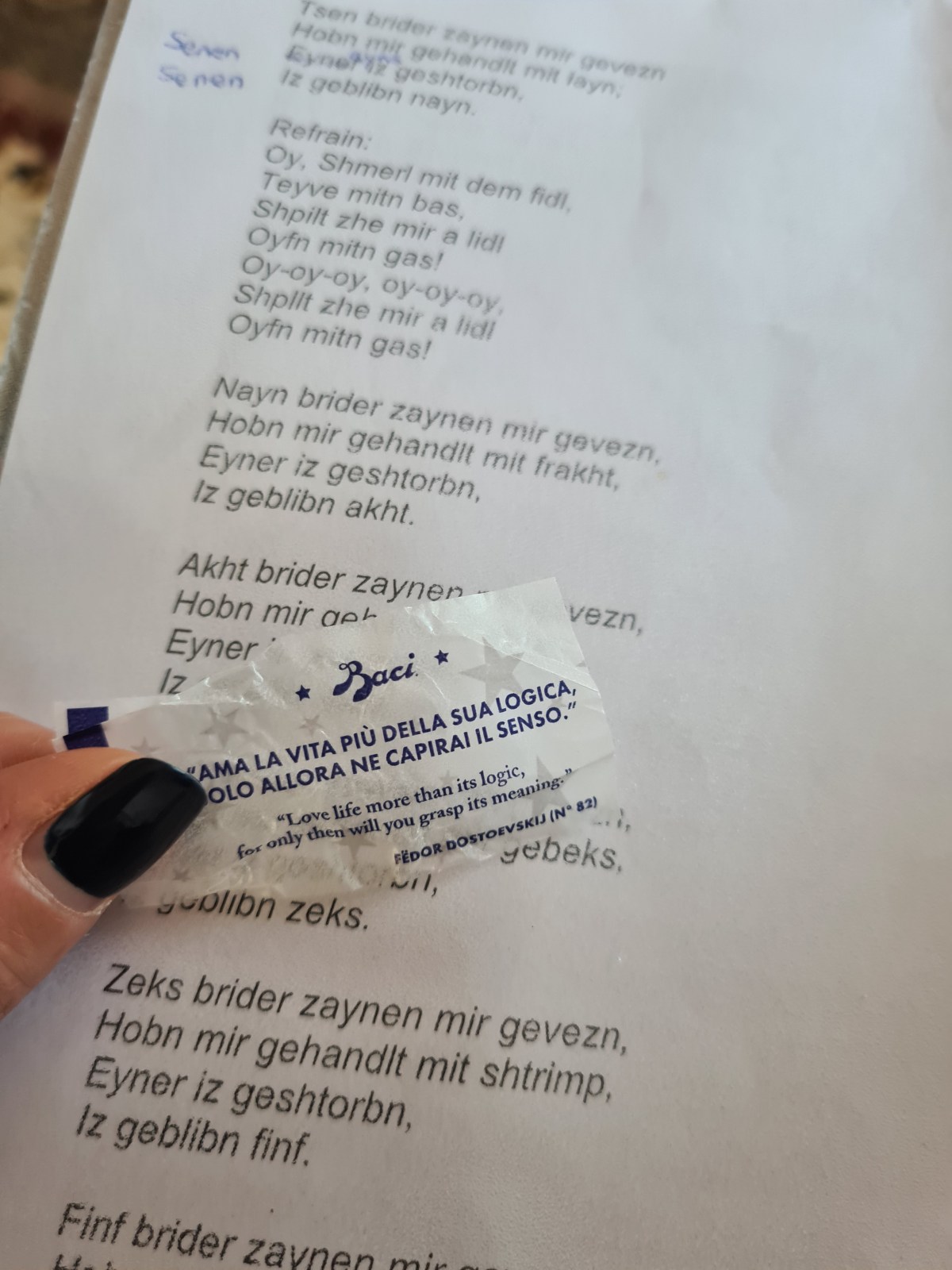“Era da anni che non stavo così comoda”. Mi è venuta dal cuore, questa considerazione, dopo il primo dei due giorni e mezzo di seminario di canti ebraici con Evelina Meghnagi.
Non che ci fossero molti motivi di stare comoda. Intanto non so cantare. Mi piace, ma non sono tanto capace. Il gruppo a cui mi univo si conosce da anni e aveva già studiato tutti i pezzi. Non sono ebrea. Non ero proprio l’unica, ma quasi. Apparentemente non c’entravo proprio nulla. Tanti motivi di stare in ansia e io tendenzialmente sto in ansia (in questo l’età non mi ha migliorato).
Perché ho accettato convinta, entusiasta e tranquilla una proposta così, senza neanche fare mezza domanda di chiarimenti? Perché la cosa si configurava come un segno del destino e un messaggio dell’universo e io, in questi casi, gongolo e mi butto.
A volte toppo clamorosamente, ma non è stato questo il caso. Una volta mi ricordo di aver pensato, a un concerto di Evelina, che per qualche motivo la sua musica riesce a tracciare un filo, un senso (se non logico, artistico), a tutti i pezzi frammentati della mia vita. Oggi lo confermo.
Ricordi dell’ulpan di Gerusalemme e dell’estate del mio primo attentato. Il fascino della sinagoga sefardita di Londra l’estate dopo la maturità, che si è saldata ai rilievi assiri del British Museum e mi ha spinto verso il percorso universitario che ancora parla alla mia anima. Mio padre che pochi giorni prima di morire mi chiede di tradurre il testo di Adon Olam. La ninna nanna struggente cantata sulla piazza del Campidoglio dopo il naufragio di Lampedusa. Il libro di ricette sefardite comprate la prima volta che sono andata a Istanbul, per difendere fin d’allora uno spazio mio in quella Turchia di altri che da allora non mi ha mai lasciato. Le danze di Eli, la memoria nei piedi, gli spettacoli senza vergogna al Pincio, a piazza di Spagna, persino al Carnevale di Viareggio. Ma anche la maimuna e quel pensiero che un giorno dovrei dipanare quel filo che lega quella festa tripolina al marzeach dei miei antichi studi.
Le identità, le lingue, gli alfabeti, le religioni, le contraddizioni del mosaico unico e particolarissimo di ciascuno. L’individuo che si muove come una medusa nel flusso potente e contraddittorio della storia. Gli strappi, gli esili, i conflitti. Queste cose sono davvero la mia essenza, quello che in mille forme diverse ho inseguito sempre. Negli studi, nel lavoro, nelle amicizie, nei viaggi, persino negli amori (forse non casualmente sempre complicati e spezzati, anche quelli).
Magari in questa inquietudine c’entra il confine di mio padre, quello che si è portato dentro tutta la vita e dove oggi è sepolto. La lingua negata di cui non mi ha mai esplicitamente parlato, ma che si vede in filigrana nella lettera persa del nostro cognome. L’attenzione e l’amore che ho sempre visto in lui per le minoranze, per la complessità di chi non entra in un’etichetta nazionale, linguistica, religiosa (ma quale uomo può essere definito con un aggettivo solo, alla fine?).
Sia come sia, non mi è facile parlare di queste cose nella vita quotidiana. E in questi giorni, oltre a cantare malamente in quattro lingue, ho parlato a macchinetta di un sacco di cose e mi sono sentita ascoltata e persino apprezzata. Cavolo, se mi serviva. Mi sono accorta che mi ero un po’ smarrita, a furia di censurare parti di me troppo ostiche per gli altri. Ho respirato a pieni polmoni, ho ricordato il mio fondamento e la mia mobile stabilità.
Sono davvero stati giorni preziosi, di cui sono infinitamente riconoscente.