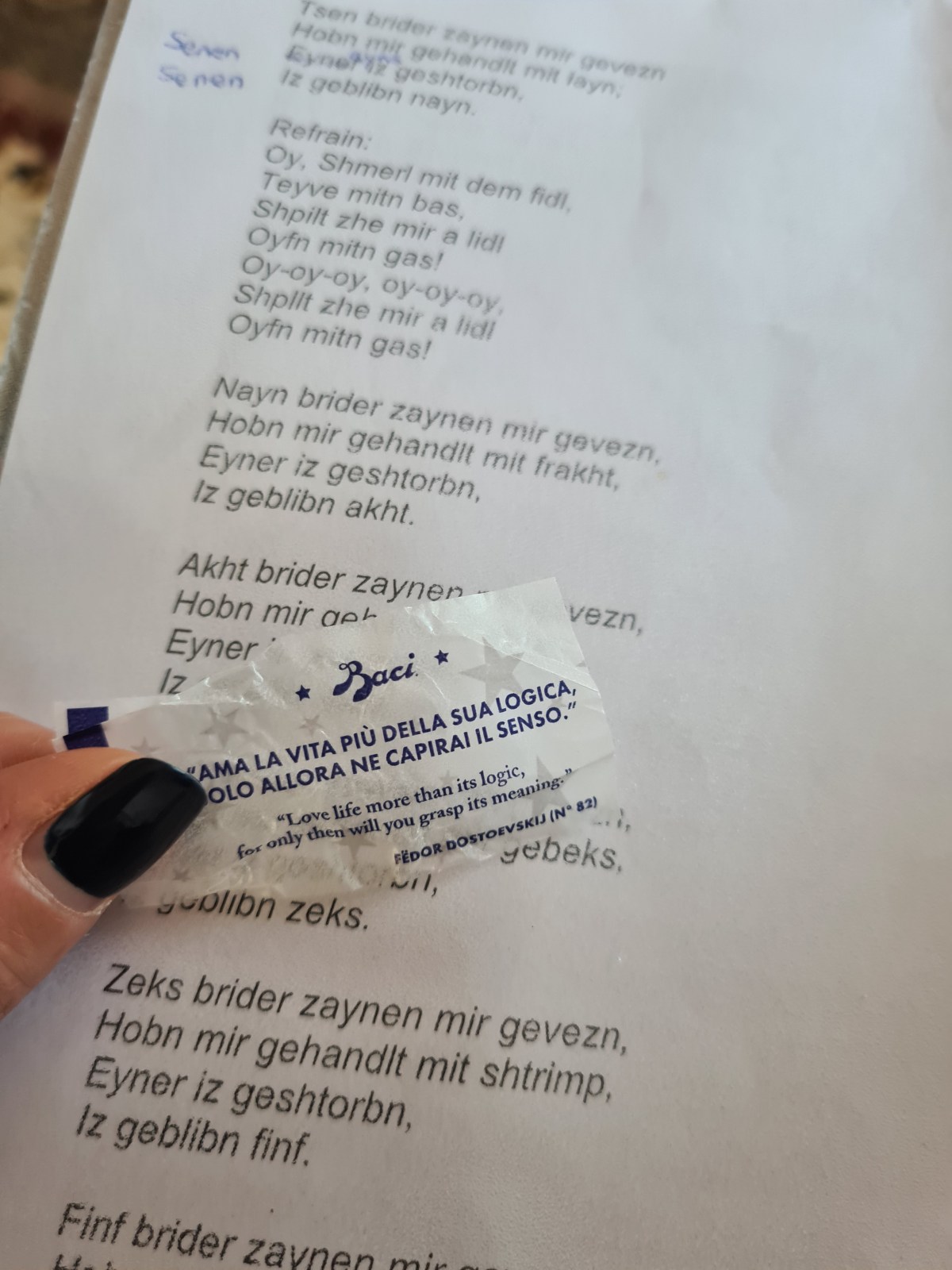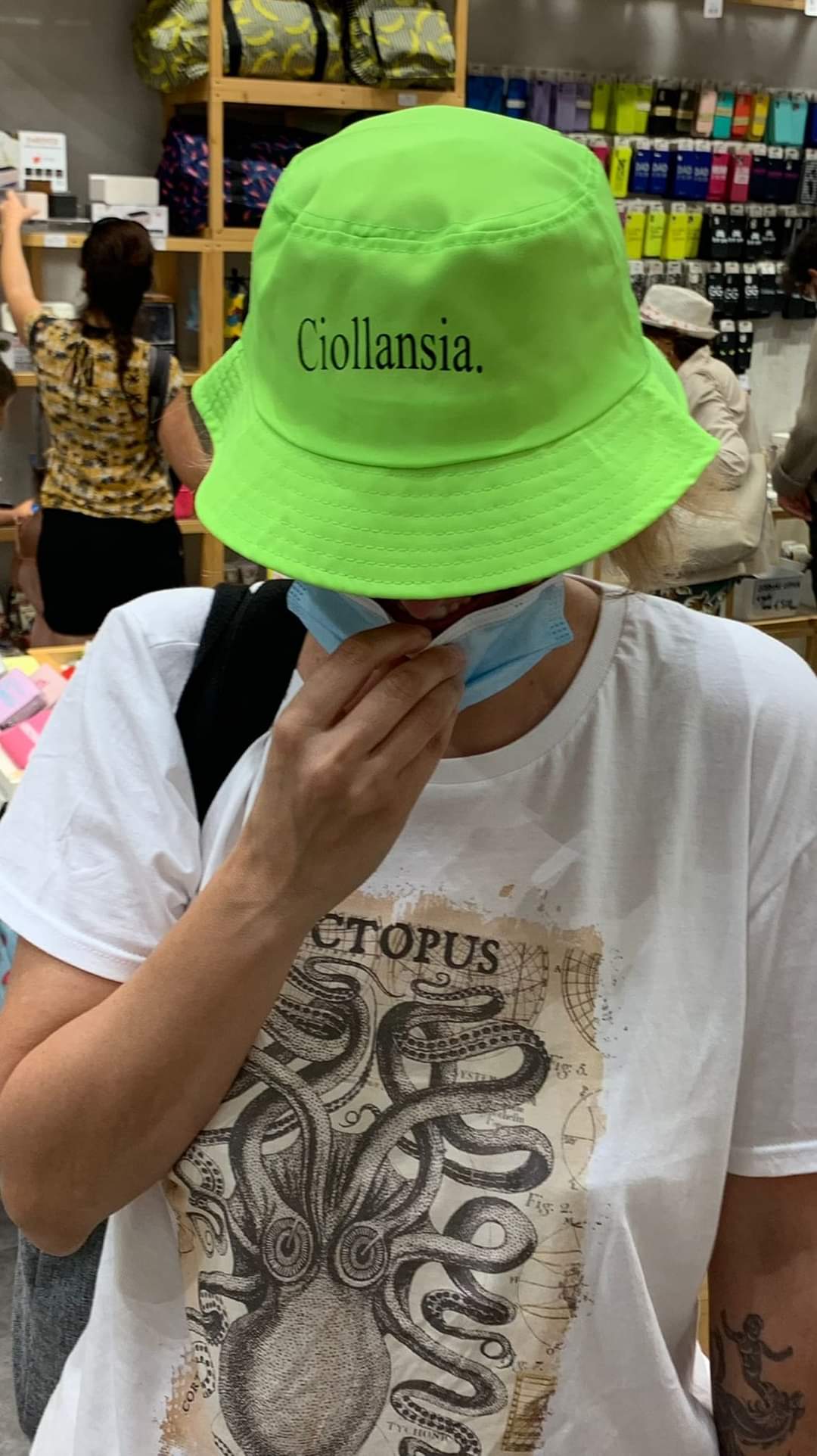Da un paio di settimane, anche attraverso alcuni scambi significativi con due amici diversissimi tra loro, mi chiedo se sia arrivato il momento di cambiare prospettiva.
Ho sempre dato per scontato il fatto che una vita degna di essere vissuta sia una vita mobile, animata da slanci, piena di fuoco, di inquietudine, di passioni. Tutta la mia vita adulta è stata così e nonostante oggi, se dovessi fare un bilancio, non sarebbe particolarmente lusinghiero, non posso dire di esserne dispiaciuta. Ho creduto in varie idee e persone, talora contro ogni evidenza, sono stata generosa di entusiasmo e di sentimenti. Ai limiti della irragionevolezza e talora fieramente (e forse ostinatamente e addirittura caparbiamente) oltre quei limiti.
Mi sono sempre riconosciuta nell’esortazione di Pedro Arrupe a innamorarsi. E di anno in anno mi rendo conto di fare più fatica, forse perché non sono capace di innamorarmi di Dio, ma vado piuttosto dietro a “tutte le cose” (persone incluse) e soprattutto all’idea stessa di me innamorata e entusiasta.
Non mi abbandona negli ultimi anni la sensazione di girare a vuoto e, peggio ancora, di un certo senso di non autenticità. Cerco di convincermi, di trovare espedienti, di distrarmi e allo stesso tempo mi ostino sempre più a raccontarmi cose che in fondo so non essere vere, insultando la stessa intelligenza di cui mi vanto.
Ma se fosse arrivato il momento di deporre questa ricerca di slanci? Se questo che oggi mi pare il rischio di una misera rassegnazione fosse invece una strada per uscire dal pantano in cui mi trovo? Forse la vita che mi aspetta in questo “secondo tempo” non somiglierà affatto a quella che ho sempre considerato felicità. Vuol dire che non sarò mai più felice?
“Non si può essere sempre felici”, ho scritto un giorno a un amico, più per recriminazione che per saggezza. Magari devo imparare un modo nuovo di essere felice.
A esserlo anche da sola, ad esempio. Ricordo tempo fa che su Facebook c’era un giochino in cui si chiedeva di pubblicare foto di momenti felici: in nessuno degli scatti che ho scelto ero sola, non ricordo chi me lo ha fatto notare. Per me fino a oggi la felicità non è solitaria. Mi angoscia la prospettiva di non avere nessuno con cui condividere le cose importanti come quelle piccole.
Eppure questo è il corso abbastanza inevitabile della mia vita. Inutile cercare di aggrapparsi disperatamente ai rapporti di amicizia che mi si presentano, caricandoli di aspettative esagerate. Come dice una canzone che amo moltissimo:
“Don’t cry out or cling in terror
Darling that’s a fatal error
Clinging to a somebody you thought you knew was yours…”
Magari poi dovrei prendere esempio dai miei due amici diversissimi tra loro (ma sicuramente entrambi diversissimi da me) e pensare seriamente di allenarmi a calmare la mente, “quello spirto guerrier ch’entro mi rugge”. Come non so bene. Inizio a guardare in faccia le mie paure più grandi e poi vediamo questo dove mi porta.