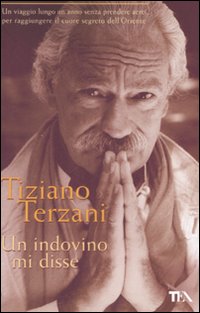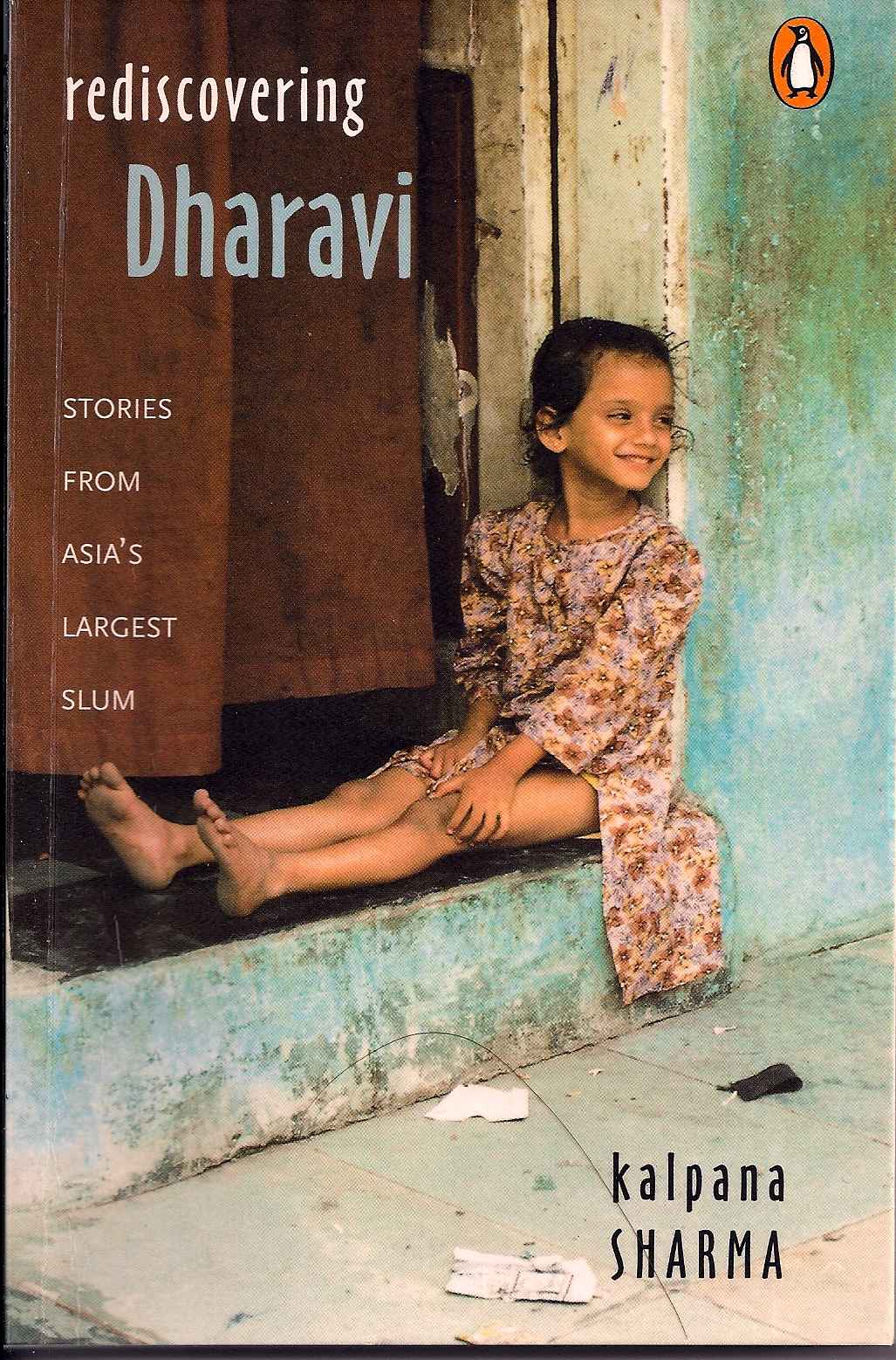Confessiamolo subito: questo post non sarebbe così difficile, da scrivere e da leggere, se le vicende di cui parlo accadessero, che so, in Belgio. Sarebbero fatti dolorosi e politiche che suscitano indignazione, ma almeno non sarei tenuta a fare alcuna premessa o disclaimer. Mi correggo: non farò premesse in ogni caso, perché credo che tutta la mia esperienza parli da sola. Però, a scanso di equivoci, mi sono documentata molto per scrivere questo post e cercherò, più del solito, di citare le mie fonti. Ci tengo davvero che la discussione, se ci sarà, sia pertinente e non ideologica.
Siamo in Israele, dunque. Quella stessa Israele giustamente citata ad esempio su alcune bacheche Facebook anche di recente per l’apertura e l’inclusione effettiva dimostrata nei confronti degli omosessuali. Ma da mesi c’è un altro argomento che ricorre prepotente nella pagine dei quotidiani. E qui ho avuto il primo sussulto, per la terminologia usata: si parla di problema degli infiltrati. Infiltrati africani, per la precisione. Approfondendo la questione, si arguisce che il termine, per l’uso del quale il governo israeliano è stato criticato anche dal Dipartimento di Stato USA, ha un suo preciso fondamento giuridico: la Legge per la Prevenzione dell’Infiltrazione, del 1954, emanata in circostanze di emergenza e rinnovata di anno in anno, fino al suo ultimo emendamento di pochi giorni fa. Si chiama così. Nel 1954 gli infiltrati erano nemici armati che si insinuavano all’interno dei confini di Israele per compiere attentati. Oggi gli infiltrati sono soprattutto eritrei e sudanesi, che varcano il confine del Sinai dopo aver passato spesso attraverso l’esperienza del sequestro e dei ricatto da parte di trafficanti senza scrupoli. Si tratta di persone in fuga da guerre e persecuzioni, a volte amici e parenti dei rifugiati che incontro ogni giorno qui in ufficio e a cui l’Italia riconosce la protezione internazionale.
La legge prevede detenzione fino a tre anni, bambini inclusi, per chiunque varchi la frontiera senza documenti, anche se chiede asilo. La pratica dei respingimenti in frontiera è comunemente praticata. Ma Israele non ha firmato la Convenzione di Ginevra del 1951? Certo che l’ha firmata. Eppure l’accesso alla procedura d’asilo è una fortuna riservata a pochi. Secondo l’associazione israeliana Avvocati per l’asilo, dei circa 25mila richiedenti asilo presenti nel Paese, all’85% è negato l’accesso alla procedura. Secondo il Dipartimento di Stato USA, alla maggior parete dei richiedenti asilo viene dato un documento che ne sospende provvisoriamente l’espulsione, da rinnovare a intervalli di pochi mesi. Ma agli altri non sembra andare molto meglio: se si guardano i dati UNHCR, delle 4.603 richieste di asilo presentate nel 2011 (a fronte di circa 16mila arrivi), 3.692 sono state respinte e a una sola famiglia è stato riconosciuto l’asilo politico.
Proprio in questi giorni è aperta la caccia all’uomo in vista di un massiccio rimpatrio coatto in Sud Sudan, Paese notoriamente a rischio, sia dal punto di vista della sicurezza alimentare che delle violazioni sistematiche dei diritti umani. Per ora non è stato autorizzato il rimpatrio coatto di eritrei e sudanesi. Per ora.
Il clima sociale e politico è incandescente. Gli africani che vivono in Israele, spesso senza alcuna forma di accoglienza, sono stati oggetto di ripetuti attacchi: molotov lanciate in case private e persino contro un asilo frequentato da bambini africani, incendi dolosi ad abitazioni, manifestazioni in cui centinaia di persone chiedono a gran voce di “deportarli tutti”. Non si può dire che i politici gettino acqua sul fuoco. Il Ministro dell’Interno ha rilasciato dichiarazioni sconcertanti: malati di AIDS, stupratori, violenti, i migranti africani avrebbero reso il sud di Tel Aviv “la pattumiera del Paese”. Se ne devono andare, con le buone o con le cattive. E se qualcuno gli obiettasse che le sue parole possono suonare un po’ xenofobe e razziste, risponde: “Lo so, ma sono motivato dall’amore per il mio Paese e dalla consapevolezza che non ne ho un altro.”
E chi ne ha un altro, oltre il proprio? potrebbe obiettare qualcuno di voi. No, qui il riferimento è chiaro ed è tutto ideologico: gli ebrei non potrebbero vivere altrove, perché sarebbero perseguitati. Israele è l’unica risposta possibile per assicurare a un ebreo di vivere in sicurezza. Secondo me, con questa frase il ministro Yishai deliberatamente mira a spostare il piano del dibattito da una questione di politica nazionale a un piano diverso. “Noi non siamo uno Stato come gli altri”, sembra voler dire. E su questo punto, sono spiacente, ma non mi sento davvero di seguirlo.
Il colpo di grazia su questa storia mi arriva da un editoriale singolarmente infelice di Abraham B. Yehoshua, pubblicato su La Stampa giorni fa. L’articolo è stato ampiamente criticato in rete (per esempio qui e qui), quindi evito di glossarlo punto per punto. Cito solo una frase su tutte: “Qual è la soluzione? Innanzi tutto bloccare la frontiera col deserto, cosa che sta già rapidamente avvenendo [con la costruzione di un muro su 140 km dei 250 km di frontiera complessivi n.d.b.*]. Se ciò non accadesse Israele potrebbe essere travolta da un vero e proprio tsunami africano”. L’uso del termine tsunami applicato all’arrivo di richiedenti asilo per noi italiani non è una novità. L’abbiamo sentita in bocca a Maroni e a Berlusconi, a proposito degli arrivi dal nord Africa (ed era stata giustamente criticata, tra gli altri da Gad Lerner). In nessun caso delle persone, fossero pure dei migranti in cerca di lavoro, possono essere accomunate a un’anonima catastrofe naturale. La cosa è tanto più grave se si hanno presenti le circostanze che hanno costretto alla fuga questi uomini e queste donne e le esperienze spaventose che hanno subito nella speranza di salvarsi la vita.
Non tsunami, dunque, e neppure infiltrati. Chiamiamoli rifugiati e interroghiamoci su cosa sono diventate le nostre società democratiche (Israele, certamente, lo è). Dobbiamo chiedercelo prima ancora che per loro, per noi e per i nostri figli. Il ministro Yishai dice che questa gente minaccia il sogno sionista. Io credo fermamente che questo sogno rischi di trasformarsi in un incubo, se non si riuscirà a tornare al rispetto delle leggi internazionali e, prima ancora, della ragionevolezza e della civiltà, come molti in Israele chiedono.
Meno di un mese fa, Anne Rose Siegel, volontaria di una ONG israeliana, ha scritto una lettera molto toccante alle comunità ebraiche della diaspora. Anche lei, come il ministro Yishai, cerca il collegamento, complicato e controverso, con gli ebrei che non vivono in Israele. Cita un celeberrimo discorso di Ben Gurion alla comunità internazionale del 1944, lo parafrasa e chiede: se invece di africani fossero ebrei gli uomini, le donne, i bambini che si vedono oggi arrivare molotov in camera da letto e che vivono nel terrore costante di essere deportati dove li aspetta carcere, tortura o morte certa… vi comportereste nello stesso modo? Ma forse si può generalizzare e dire: se fossero i vostri figli, i vostri amici, i vostri parenti… vi comportereste nello stesso modo? Non crediamo forse di appartenere a un’unica famiglia umana, chi per un motivo chi per l’altro?
*nota del blogger