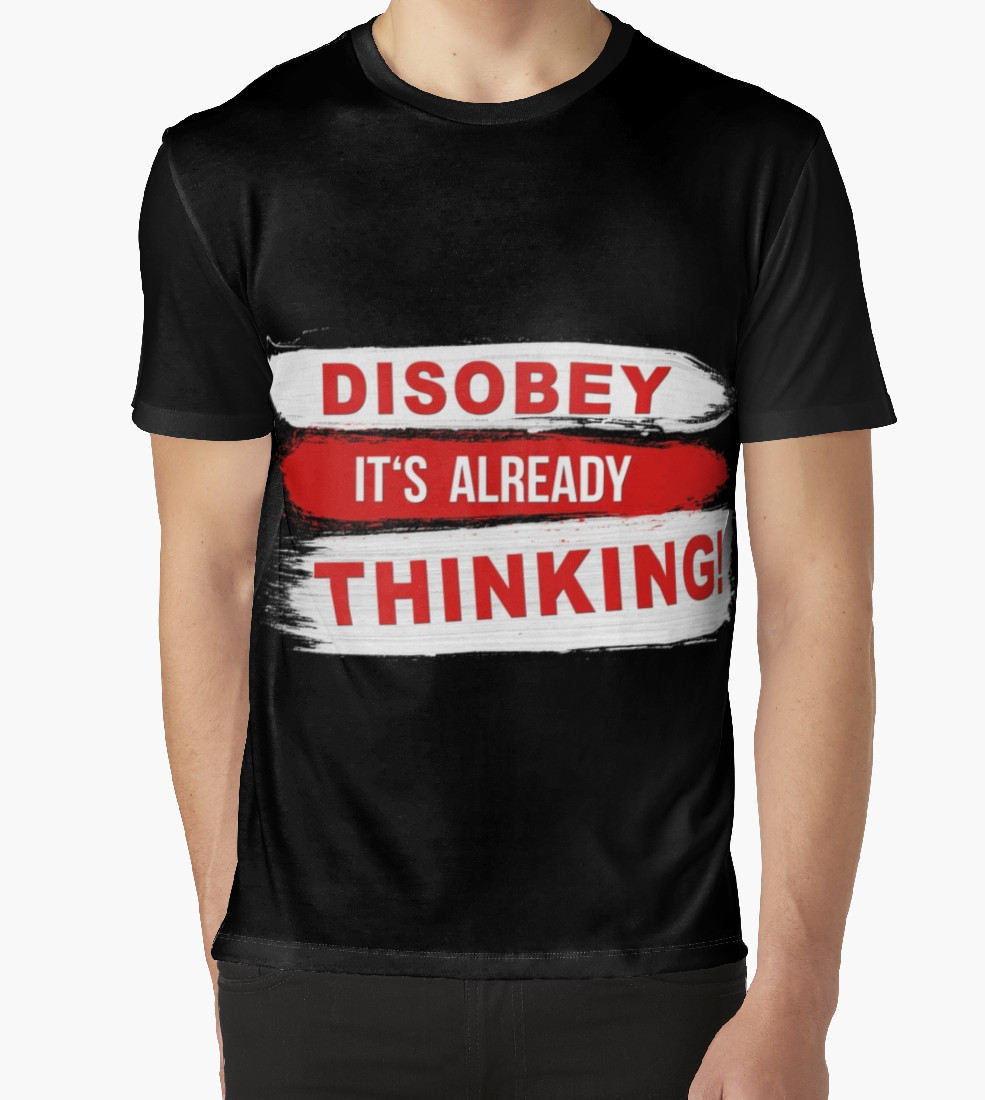Domenica scorsa, per rifarci da qualche giorno di clausura a causa dell’influenza, io e Meryem siamo state a spasso per quasi tutto il giorno. Proprio alla mostra dei Numeri, insieme a varie cose interessanti, abbiamo avuto modo di riflettere sulla relatività dei calendari e su quanti modi possibili esistono per definire date (che per alcuni sono) storiche.
Eppure, in barba alla ragionevolezza storico-scientifica, oggi ho voglia di festeggiarlo, questo 2768° Natale di Roma. Mi piacerebbe partecipare alle iniziative proposte dal comune (visite guidate, ingresso gratuito nei musei, illuminazioni…): con tutte le difficoltà che ci sono e che non staremo qui oggi ad elencare, credo faccia un gran bene a noi romani ricordare che la nostra è una città speciale e meravigliosa.
Domenica, non del tutto studiatamente, uscite dalla mostra abbiamo reso omaggio alla Città Eterna e al suo talento più straordinario: riuscire a stupirci e a sorprenderci sempre con qualcosa di nuovo. Quest’anno al corteo storico classico lungo i Fori, a cui negli anni scorsi abbiamo partecipato, abbiamo preferito il Nagar Kitan della comunità sikh. Perciò abbiamo puntato con decisione verso Piazza Vittorio.
 Meryem là per là era convinta di essere l’unica di tutta la folla variopinta a parlare italiano. Non so se l’aver incontrato vari amici vistosamente italofoni incuriositi come me dalla festa l’abbia fatta ricredere. Una cosa è certa: è rimasta assolutamente rapita dal fascino delle esibizioni dei “pirati”, che saltavano roteando scimitarre, sbattendo bastoni e facendo roteare delle reti colorate con delle palline (che per l’entusiasmo di documentare io alla fine sono riuscita a prendermi in testa). E’ rimasta colpita anche dalla signora rom che, passando accanto alla processione, ha gridato con entusiasmo: “Buona festa!”.
Meryem là per là era convinta di essere l’unica di tutta la folla variopinta a parlare italiano. Non so se l’aver incontrato vari amici vistosamente italofoni incuriositi come me dalla festa l’abbia fatta ricredere. Una cosa è certa: è rimasta assolutamente rapita dal fascino delle esibizioni dei “pirati”, che saltavano roteando scimitarre, sbattendo bastoni e facendo roteare delle reti colorate con delle palline (che per l’entusiasmo di documentare io alla fine sono riuscita a prendermi in testa). E’ rimasta colpita anche dalla signora rom che, passando accanto alla processione, ha gridato con entusiasmo: “Buona festa!”.
Quella stessa mattina, mentre camminavamo verso l’Esquilino, siamo passate davanti alla chiesa ucraina, dove un nutrito gruppo di fedeli che seguiva la messa dalla piazza antistante (la chiesa è piccolissima) e abbiamo anche visto un ambulante musulmano che pregava sul marciapiede. Una piccola antologia della città multireligiosa che ho imparato a scoprire in questi anni e che mi piace far notare anche a Meryem.
Ieri poi ho completato la mia personale celebrazione del Natale di Roma con una visita alla Moschea di Monte Antenne, la più grande d’Europa. Un edificio imponente, in cui sampietrini e travertino convivono con le geometrie riprese dall’Andalusia spagnola e con le cupole che ammiccano a Istanbul, la Roma del Bosforo. L’unica cosa che mi ha fatto un po’ tristezza è stato vedere che, dopo il richiamo della preghiera, la moschea restava occupata solo da noi visitatori. Il che, ovviamente, è normale, considerato il fatto che era un pomeriggio lavorativo e che la Moschea sorge alle pendici di Parioli, in un luogo sostanzialmente distante da negozi e abitazioni. “Se fossimo a Centocelle, a questo punto sarebbero già arrivate un centinaio di persone”, ha commentato uno dei musulmani presenti, aggiungendo anche: “Questo per questo luogo è un grande vantaggio, così resta bello e pulito”. Ora io non so se questa chiosa fosse dettata dal desiderio di non sfigurare o da una convinzione effettiva. Io, per conto mio, preferirei che questo spazio così bello e significativo non restasse la moschea delle grandi occasioni, ma potesse effettivamente servire a raccogliere la fede vissuta di tanti uomini e donne. Una fede che fa rumore, non è sempre esteticamente piacevole e magari, in effetti, sporca anche. Ma è la vera ricchezza che tutti noi abbiamo bisogno di scoprire.
Mi torna in mente un passo del discorso del Papa al Presidente Mattarella in visita al Vaticano: “Un sano pluralismo non si chiuderà allo specifico apporto offerto dalle varie componenti ideali e religiose che compongono la società, purché naturalmente esse accolgano i fondamentali principi che presiedono alla vita civile e non strumentalizzino o distorcano le loro credenze a fini di violenza e sopraffazione. In altre parole, lo sviluppo ordinato di una civile società pluralistica postula che non si pretenda di confinare l’autentico spirito religioso nella sola intimità della coscienza, ma che si riconosca anche il suo ruolo significativo nella costruzione della società, legittimando il valido apporto che esso può offrire”. Una convivialità della cittadinanza attiva, insomma, che faccia delle differenze un punto di forza per accogliere, sperimentare, immaginare.
Il mio augurio a Roma, oggi, è che non smetta di essere metropoli nello spirito. Per quanto limitata, provinciale e chiusa nei suoi confini possa essere l’Italia o l’Europa in questa stagione, Roma non smetterà mai di guardare al mondo. Di più. Dentro Roma, il mondo, ci sta comodamente tutto.